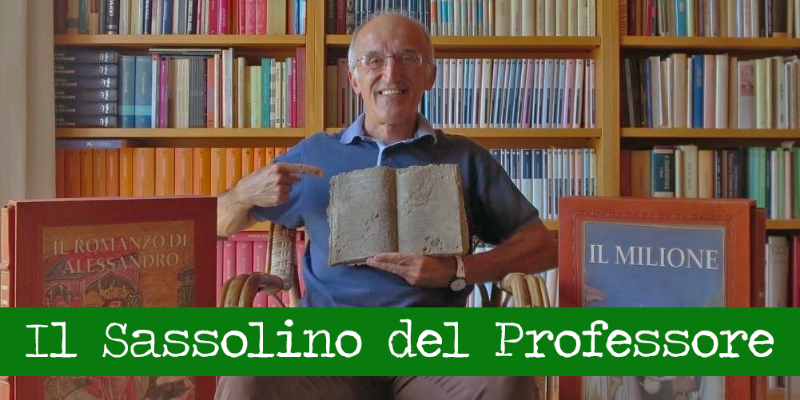“Con i suoi orologi marini, Harrison tastò il terreno dello spazio-tempo. Contro ogni previsione, riuscì a usare la quarta dimensione, quella temporale, per collegare punti diversi del globo tridimensionale. Carpì alle stelle il segreto per orientarsi nel mondo” (Dava Sobel, “Longitudine”)
In ambito letterario il gioco dei rimandi è sempre in agguato. Stavo assistendo, durante la splendida manifestazione “Lector in fabula”, che quest’anno aveva come tema “La misura del mondo”, ad una interessante presentazione di un libro in cui si parlava dell’incontro tra due geni tedeschi, il matematico Carl Friedrich Gauss e il geografo Alexander von Humbold, che nel XIX secolo misero le basi della topografia e della geografia moderna.
Immediatamente la mia mente è andata al libro “Longitudine” della divulgatrice Dava Sobel. L’opera, pur essendo di impostazione scientifica, si legge come un romanzo appassionante.
Nel 1714 il Parlamento inglese offrì una cifra davvero notevole per chi fosse riuscito a risolvere in diretta il calcolo della longitudine su una nave in piena navigazione. Il problema non era mai stato risolto – al contrario del calcolo della latitudine, che si otteneva facilmente attraverso un sestante, che sembra fosse utilizzato sin dagli antichi egizi.
Non essere in grado di calcolare esattamente la longitudine provocava disastri marittimi, con affondamenti di navi e relativa perdita di vite umane e dei carichi.
In questo problema si erano cimentati invano anche menti eccelse quali Galileo e Newton, i quali tentarono senza successo soluzioni per via astronomica, cercando di utilizzare le stelle quali sistema di riferimento.
Incredibilmente la soluzione riuscì a darla un orologiaio inglese autodidatta, di nome John Harrison. Egli postulò un semplicissimo principio: se si porta sulla nave un orologio tarato con l’ora di Londra, da cui passa il meridiano zero, basterebbe calcolare quanto il sole sia inclinato rispetto allo zenit al mezzogiorno di tale orologio in qualunque parte del mondo, per calcolare la longitudine di tale luogo.
La brillante soluzione aveva solo un enorme problema pratico: l’orologio di bordo, tarato su Londra, doveva essere molto preciso, perché ogni perdita di precisione significava errare nel calcolo della longitudine. Harrison costruì un primo prototipo di orologio di precisione ma impiegò più di quarant’anni per perfezionare via via lo strumento, e, soprattutto, per convincere la comunità scientifica della bontà del suo metodo rispetto ai tentativi astronomici. Purtroppo molti tentarono di boicottarlo, come talvolta capita nei confronti di novità stravolgenti, anche nel campo scientifico. Ma fu lui a vincere, tanto che i suoi orologi furono utilizzati per tanti anni, prima dell’arrivo degli strumenti odierni a base Gps.
Alla fine il problema di una misura di una dimensione dello spazio fu risolta attraverso la precisione della misura del tempo.
Tanti anni dopo fu Albert Einstein a dirci che lo spazio e il tempo sono indissolubilmente legati dalla teoria della relatività che governa l’universo. Ma, come dice la citazione iniziale, due secoli prima fu un orologiaio ad anticiparne il legame.
Mi domando, in chiusura, tra il serio e il faceto, se mai un giorno si riuscirà a trovare il modo per misurare con maggior precisione i luoghi dell’anima.